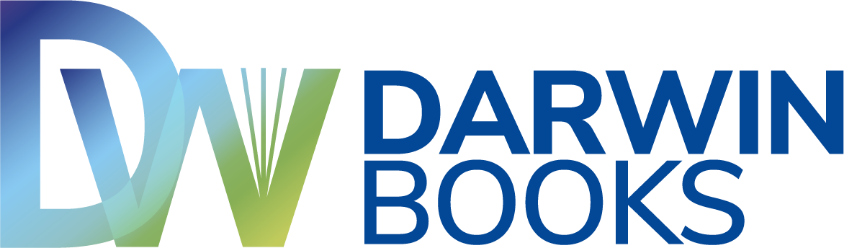Indice
- Ringraziamenti
- Dedica
- Prefazione
- Capitolo primo Economia, persona, sviluppo
- 1. Un’economia di persone
- 2. La scintilla di Jobra
- 3. Che cosa ci insegna l’esperienza del microcredito?
- 4. Quale sviluppo e per chi?
- 5. Ci serve più ricchezza o più libertà?
- 6. Vogliamo più ricchezza o più benessere?
- 7. Ci serve un patto o un contratto?
- 8. Dal contratto al patto e dall’individuo alla persona
- 9. Verso un nuovo umanesimo economico
- Capitolo secondo Il mercato del credito: asimmetrie e razionamento
- 1. Le virtù del mercato
- 2. Problemi di agenzia e razionamento del credito
- 3. La teoria economica alle prese con il microcredito
- 4. Conclusioni
- Capitolo terzo Le radici antiche di un’idea moderna: dai Monti di Pietà alla Grameen Bank
- 1. Introduzione
- 2. Le relazioni creditizie
- 3. L’innovazione istituzionale del Rinascimento italiano: i Monti di Pietà
- 4. I fondi rotativi e le associazioni di credito
- 5. Le banche di credito cooperativo
- 6. La microfinanza moderna
- Capitolo quarto Il credito relazionale: varietà e innovazioni metodologiche
- 1. Il prestito di gruppo: una nuova forma di credito relazionale
- 2. Le relazioni di credito: strutture relazionali orizzontali, verticali e sovrapposte
- 3. Le relazioni come collaterale sociale: meccanismi di controllo e pressione tra pari
- 4. Dal gruppo alla persona: verso nuove forme di credito relazionale
- Capitolo quinto Capitale sociale, reti relazionali e istituzioni capacitanti
- 1. La scatola nera del capitale sociale
- 2. La componente strutturale del capitale sociale: le reti sociali e il microcredito
- 3. Il capitale sociale come lubrificante delle interazioni economiche
- 4. Capitale sociale e istituzioni capacitanti
- 5. «Social capital policy»: quale ruolo per le istituzioni e la società civile?
- 6. Le istituzioni di microfinanza come istituzioni capacitanti
- Capitolo sesto Preferenze sociali e reciprocità
- 1. Introduzione
- 2. Conflitto e cooperazione tra egoisti
- 3. Preferenze sociali: altruismo ed equità
- 4. Neuroscienze sociali, teoria della mente e simulazione incarnata
- 5. Reciprocità e teoria dei giochi psicologici
- 6. Conclusioni
- Capitolo settimo La componente fiduciaria nella relazione creditizia
- 1. Introduzione
- 2. Fiducia, affidabilità, reciprocità
- 3. Fiducia e rispondenza fiduciaria
- 4. Una relazione di microcredito fiduciaria
- 5. Io penso che tu creda che io faccia...
- 6. Le dinamiche fiduciarie
- 7. Quel furfante di Hume e le relazioni di microcredito
- Capitolo ottavo L’esclusione finanziaria e la microfinanza moderna
- 1. Introduzione
- 2. Chiudere le porte allo sviluppo: l’esclusione finanziaria
- 3. La risposta della microfinanza: le dimensioni del fenomeno
- 4. I più poveri tra i poveri?
- 5. La povertà dei paesi ricchi: la microfinanza in Europa
- 6. Il microcredito in Italia: fenomeno nuovo o riscoperta delle origini?
- Capitolo nono La microfinanza al bivio: stato, mercato e innovazione
- 1. Le sfide della microfinanza oggi: «outreach», sostenibilità ed efficienza
- 2. Microfinanza e «welfare mix»: «smart subsidies», coordinamento ed esternalità
- 3. La commercializzazione della microfinanza: opportunità e rischi di una controrivoluzione
- 4. Espandere la frontiera delle possibilità di accesso: innovazione e regolamentazione
- Conclusioni
- Riferimenti bibliografici